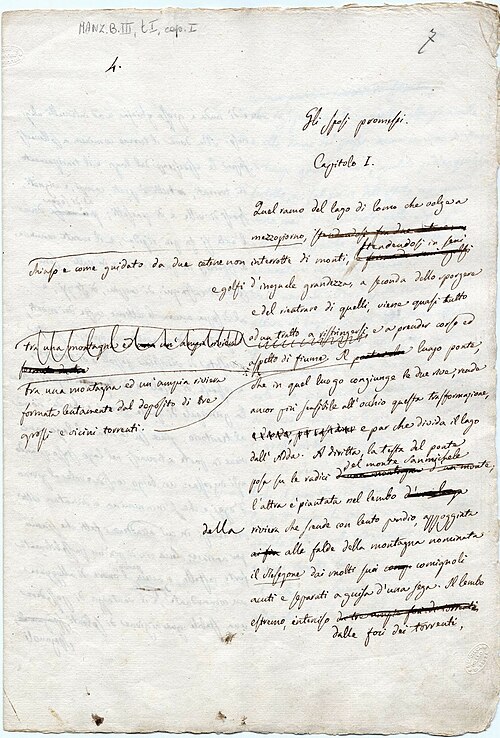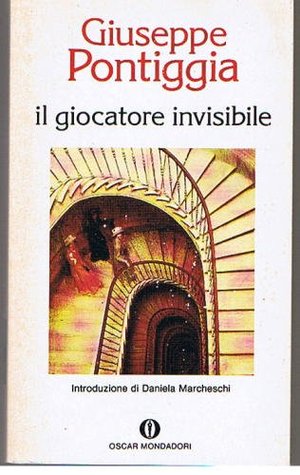Introduzione e status quaestionis:
Il tormentato rapporto di Ezra Pound (1885-1972) con Arnaut Daniel, e più in generale con la lirica trobadorica, passa attraverso una fascinazione nata dai suoi studi presso l’Hamilton College di New York, e in seguito durante il dottorato mai concluso presso la University of Pennsylvania, e si struttura in una serie di fasi susseguenti, prima fra tutte quella del riconoscimento del limite linguistico delle traduzioni in lingua inglese operate en fin de siécle sulla scorta dei mitologizzanti preziosismi vittoriani, e con un apprezzabile mea culpa, eslege se si pensa a Pound come a un eccentrico innovatore, ben meno se si riconosce il suo rispetto devozionale per la letteratura trobadorica, Pound riconosce di aver di ciò peccato nell’operare le traduzioni di Guido Cavalcanti. È inoltre doveroso premettere alcuni dettagli sul confronto che Pound ebbe con la lirica arnaldiana: innanzitutto, Oltreoceano la letteratura europea medievale non aveva ancora visto un’incontrastata accettazione critica, né tantomeno era reverenzialmente studiata e ammirata; seguitamente, Pound approderà alla lirica del trovatore perigordino attraverso una prima fascinazione per i trovatori Peire Cardenal, Raimon de Miraval e Guiraut de Bornelh, e anche tramite la mediazione dello scritto esoterico Les secretes des troubadours. De Parsifal à Don Quichotte (1906) dello «stravagante scrittore occultista»[1] Joséphine Péladan, che egli acquistò a Parigi durante un suo deluso soggiorno.