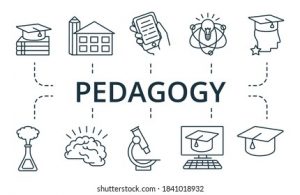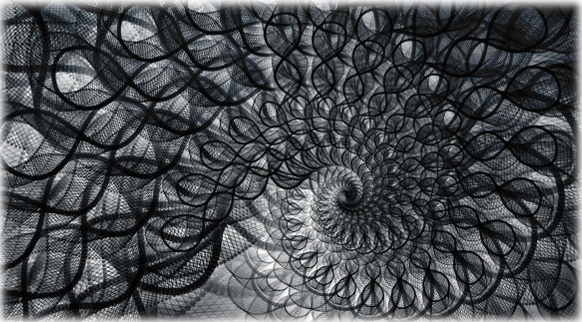Per Roger Deakin, esteticamente la Natura ha creato le farfalle come un omaggio per i fiori, portando la bellezza in volo. Sarà anche un insegnamento al rispetto, quando l’entomologo ricorrerà alla retina. Camilla ha posato sulla battigia, al mare. Pare che l’abbigliamento omaggi le onde, tramite la “clessidra” del busto con la strozzatura d’un fiocco. Se noi guardiamo il mare, è anche affinché la memoria ci ispiri. Ma quanto il braccio sinistro, piegandosi, avrebbe assunto la configurazione d’una retina per farfalle? Il petalo deriverebbe dal sole all’orizzonte, coi propri raggi sull’acqua. Più realisticamente Camilla danza. Il boxer da donna si percepirebbe all’infiorescenza per la rete, e da un’incandescenza che riposasse col rosa.
...all we need is philosophy