Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo La nascita del mondo moderno di Bayly
Il Dopoguerra è un libro monumentale sul periodo immediatamente successivo alla seconda guerra mondiale, un periodo medio-lungo (1945-2005), il cui intento generale è ben chiarito dal sottotitolo dell’opera: Come è cambiata l’Europa dal 1945 a oggi. Lo storico Tony Judt analizza compiutamente la storia europea dal secondo dopoguerra ai giorni prima della nuova grande crisi economica. Nonostante il libro sia stato pubblicato durante l’attuale periodo di crisi (2007), Judt si ferma esattamente al principio di essa, sicché non sarà in grado di considerare i rivolgimenti e stravolgimenti attuali. Infatti, il libro termina sulla traccia di nuove prospettive dell’Europa contemporanea, ma non trae le possibili conseguenze di un Unione Europea rafforzata (o indebolita) in base alle scelte in reazione di quest’ultima crisi.
Il libro tratta la storia delle due Europa, quella Occidentale e quella Orientale, secondo momenti distinti, sebbene congiunti dal medesimo lasso temporale. In questo modo Judt mostra come la nascita dell’Europa allargata (dunque, non solo quella Occidentale) sia, dal punto di vista diacronico, bipartita secondo due direttrici temporali ben distinte. Da un lato, c’è l’Europa occidentale, che spinge l’economia e definisce i valori di quella che è la zona europea, dall’altro lato, c’è l’Europa orientale, che insegue il sogno dell’Europa e, allo stesso tempo, necessita di ripensare alla propria identità in modo autonomo.
Tony Judt inizia la sua trattazione dal 1944-1945, periodo finale della seconda guerra mondiale, momento centrale per comprendere il nuovo assetto dell’Europa, dominato da una nuova geografia etnica e politica, laddove il riassetto globale è dovuta ai genocidi perpetuati durante la seconda guerra mondiale e allo spostamento massiccio di intere popolazioni, ricacciate in luoghi diversi da dove erano rispetto al periodo precedente la seconda guerra mondiale. In particolare, in questo periodo ci saranno le conseguenze più devastanti per la Germania, fino a quel momento non toccata dalle devastazioni della guerra, e per le popolazioni toccate dall’avanzata inarrestabile dell’armata rossa sul fronte orientale:
I nazisti hanno sfruttato il più a lungo possibile la ricchezza delle proprie vittime, talmente bene che soltanto a partire dal 1944 la popolazione civile tedesca ha iniziato a sentire gli effetti delle restrizioni e della scarsità di merci tipiche dei periodi di guerra. A quel punto, comunque, il conflitto stava ormai chiudendosi, prima con i bombardamenti aerei e poi con la simultanea avanzata delle truppe alleate da est e da ovest. Proprio in questo ultimo anno di guerra, durante il periodo relativamente breve di scontri effettivi a ovest dell’URSS, si verificarono le distruzioni più spaventose.[1]
La Germania fu immediatamente occupata ed emerse subito, con estrema chiarezza di tutti gli Stati ed eserciti occupanti, che essa sarebbe stata la chiave di volta dell’intera ricostruzione dell’Europa. La partita si giocava sul futuro incerto della Germania, tra la preoccupazione di non ridestare il senso di sconfitta e frustrazione proprie del primo dopoguerra, e il problema di evitare un suo sistematico riarmo. In realtà, i due problemi erano congiunti. Emerse piuttosto in fretta la connessione stringente tra la ripresa economica e politica della Germania e il suo riarmo: la forza politica di una nazione è sempre e indissolubilmente legata alle sue forze armate. Allo stesso tempo, dopo la scoperta dei crimini dei Nazisti, ora definiti “crimini contro l’umanità” (concetto coniato proprio dopo l’olocausto), c’era l’imbarazzo generale delle autorità di fronte alla ricostruzione. I nazisti godettero di un grande appoggio nella popolazione e, anche quando si volesse considerare tale popolazione come soggiogata da una piccola banda di criminali, rimaneva il problema di riuscire a non colpevolizzare l’intera nazione tedesca ma, allo stesso tempo, riuscire a punire i principali colpevoli. Più che una questione morale di giustizia era un problema di scendere a patti:
L’8 maggio 1945, quando si concluse la guerra, in Germania c’erano 8 milioni di nazisti. A Bonn, su 112 medici, 102 erano o erano stati membri del partito. Nella città di Colonia, ridotta in macerie, dei 21 specialisti del Dipartimento acquedotti (le cui competenze avevano un’importanza fondamentale per la ricostruzione dei sistemi di distribuzione idrica e degli impianti fognari), 18 ne avevano fatto parte. Nella Germania del dopoguerra la gestione dell’amministrazione civile, della sanità pubblica, della ricostruzione urbana e dell’impresa privata fu inevitabilmente assunta da persone di questo genere, per quanto sotto supervisione degli Alleati. Non era assolutamente immaginabile escludere dagli affari della Germania.[2]
Non sarebbe stato pensabile poter ricostruire la Germania senza manodopera specializzata ex nazista. Divenne subito evidente che nell’immediato bisognava accantonare l’obbiettivo di condannare il nazismo in ogni sua forma, ma limitarsi a trovare i quadri dirigenti del partito, per condannarli. Il maggior numero di processi si ebbe, comunque, dopo il 1950, quando la ripresa economica incominciava a lasciar sperare per il futuro. La concomitante formazione dei due blocchi e la conseguente guerra fredda determinò il tentativo iniziale, e fallimentare, tentativo di denazificazione della Germania.
Il Judt mostra con un grande acume e precisione, precisione di chi cerca le cause per un fenomeno che non si condivide in tutte le sue forme, il processo di formazione dello Stato assistenziale contemporaneo. La sua nascita e la sua dimensione, prima sconosciuta nel mondo, non si può comprendere se non nel quadro di un continente intero, l’Europa, devastato dalla guerra e, subito dopo, vessato dai problemi della sua ricostruzione. Bisognava ripartire da capo, bisognava riedificare l’intero apparato statale, ricostruire le industrie, riparare le infrastrutture. Allo stesso tempo era necessario investire cospicui capitali per comprare derrate alimentari dagli Stati Uniti, e così pure le medicine e molti altri generi alimentari. La fine della seconda guerra mondiale determinò la fine dello sforzo bellico, che comportò la presa di coscienza del suo prezzo. Nessuno avrebbe mai più potuto fremere per una nuova ondata di interventi militari, non dopo che la guerra divenne un fenomeno talmente distruttivo da coinvolgere qualunque elemento della popolazione umana. Ci fu un consenso unanime su chi dovesse prendersi cura della ricostruzione: lo Stato. Dall’Inghilterra all’Italia tutta la popolazione europea era concorde nel considerare lo Stato come il centro della ripresa, come il centro sociale dal quale ripartire perché investito del compito di dover far riavviare l’intero apparato economico e infrastrutturale. Se non si comprende questa esigenza, se non inquadra con precisione il motivo per cui lo Stato divenne il principio e il fine dello sforzo di tutte le forze sociali, se non si chiarifica questa ragione non si riesce a comprendere perché lo Stato contemporaneo abbia assunto una dimensione inimmaginabile in precedenza. Quando gli attuali critici dello Stato contemporaneo, in particolare per quanto riguarda la sua spesa e il suo coinvolgimento nell’economia, lanciano strali e maledizioni contro questo gigante obeso e onnivoro, dovrebbero, piuttosto, andare a ricercare i motivi per cui quello stesso Stato fu così necessario per far rinascere l’economia postbellica. Questa dimenticanza è grave almeno per due ragioni. In primo luogo perché consente di capire il processo che ha portato alla formazione di ciò che essi stessi criticano, così da poter anche comprendere le ragioni contro cui essi devono lottare (è troppo comodo dire che qualcosa è sbagliato, senza prendersi minimamente la briga di capire in che senso lo sia e perché lo è). In secondo luogo, essi avrebbero risposte migliori se tenessero conto delle ragioni storiche, che sono sempre ragioni pragmatiche (la storia è l’insieme delle soluzioni, più o meno corrette o scorrette, di un insieme di problemi reali), per cui si è arrivati a prendere determinate decisioni economiche e politiche. Solo attraverso questa conoscenza si può pensare di ragionare in termini costruttivi e corretti, in modo tale di evitare di rientrare in logiche superabili ma non necessariamente superate. Lo Stato, dunque, aveva un compito: pianificare.
Cos’era la “pianificazione”? Il termine è fuorviante. Ciò che tutti i suoi sostenitori avevano in comune era la credenza in un più attivo ruolo dello Stato negli affari sociali ed economici. A parte questo, dominava una grande varietà di interpretazioni, in genere conseguenza di specifiche tradizioni politiche nazionali.[3]
La storia non è solo un fatto politico o economico, giacché gli uomini non sono solo operatori economici né prendono le loro decisioni esclusivamente sulla base di scelte di ideologia politica. La storia è l’insieme delle persone dotate di determinate credenze e conoscenze sul mondo a partire dalle quali essi prendono determinate scelte piuttosto che altre. In questo senso, il modo di fare storia di Tony Judt segue una concezione globale del fare storia, vale a dire quell’archetipo ideale presente sin dai tempi di Erodoto, il primo storico, che concepisce la storia come un tutto. In questo modo, nel Dopoguerra viene considerato l’aspetto sociale nel suo più ampio senso, sia dal punto di vista della prospettiva generazionale che intellettuale. In particolare, dopo la seconda guerra mondiale gli intellettuali giocarono un ruolo di primo piano, in una società ormai laicizzata e prossima al consumo di massa di materiali informativi di alto livello di complessità (considerazione, questa, della cultura dell’informazione di massa non sufficientemente trattata da Judt che, in questo si rivela ancora troppo legato ad una visione più tradizionale di considerare i soli intellettuali rispetto al fenomeno della industria culturale, fenomeno così importante per la novità e per le conseguenze). Gli intellettuali del secondo dopoguerra erano giovani, non potevano portare la testimonianza dell’esperienza precedente alla seconda guerra mondiale, cioè del primo dopoguerra, ma avevano l’idea, globalmente accettata, che il mondo potesse essere cambiato per il meglio perché era possibile da plasmare:
Gli intellettuali europei del dopoguerra avevano fretta e mal sopportavano i compromessi: erano giovani. Nella prima guerra mondiale era rimasta uccisa un’intera generazione di giovani, ma dopo la seconda a sparire fu invece una larga schiera di uomini più anziani e screditati. Il loro posto fu preso da scrittori, artisti, giornalisti e attivisti troppo giovani per ricordare la guerra del 1914-1918, ma impazienti di recuperare gli anni perduti nella successiva. Sul piano dell’esperienza politica, si erano fatti le ossa nell’era dei fronti popolari e dei movimenti antifascisti; e quando ottennero fama e influenza, spesso per il coraggio dimostrato in guerra, erano ancora molto giovani, almeno secondo i tradizionali parametri europei. Al termine del conflitto, Sartre aveva 40 anni, Simone de Beauvoir 37 e Camus, il più influente di tutti gli intellettuali francesi, appena 32 (…).[4]
Inquadrato il fenomeno generale, Judt passa sempre a parlare delle singole situazioni dei vari stati e delle loro peculiarità. L’Italia, nel contesto culturale europeo, il nuovo e più importante luogo di discussione di idee e concetti, era una piccola appendice rivolta verso sud, isolata e provinciale perché già provinciale al suo interno. Judt, che non è certo di origini italiane, manifesta una certa spenta curiosità nei confronti del provincialismo italiano, il quale ha saputo produrre opere di rilievo solo nella letteratura di intrattenimento e, comunque, sempre rivolta ad un pubblico limitato. L’Italia sin dal 1700 è una terra simile alla Grecia medioevale: isolata, incurante del proprio isolamento, la cui apertura rischierebbe di apportare troppi svantaggi a chi mantiene le posizioni di rilievo nella società. Così:
Nel primo dopoguerra, la reputazione morale della vasta maggioranza degli intellettuali italiani era quindi riflesso della posizione internazionale piuttosto ambigua del paese, troppo scomodamente compromesso con il passato autoritario per prendere posto al centro della scena nell’Europa postbellica. In ogni caso, l’Italia occupava già da tempo una posizione stranamente periferica nella cultura, forse a causa delle tendenze centrifughe che contraddistinguono la storia del paese: ogni grande città (Napoli, Firenze, Bologna, Milano, Torino) formava un piccolo mondo separato, con le proprie università, i propri giornali, i propri circoli accademici e la propria intelligencija. Roma era sorgente dell’autorità, fonte dei finanziamenti e luogo del potere, ma non monopolizzò mai la vita culturale della nazione.[5]
Se gli italiani hanno sempre saputo produrre qualcosa di meritevole, è perché gli ingegni rari si sono rivolti al più vasto ambito della cultura europea, sono stati disposti ad emigrare per ragioni intellettuali e culturali, abbandonando la propria terra, i propri interessi locali per ricercare una maggiore apertura nei paesi ospitanti e di cui hanno saputo spesso fare la fortuna. L’ingegno italiano non è dell’Italia o in Italia. L’ingegno italiano, dunque, è assente dalla penisola da tre secoli. E continuerà ad esserlo.
La formazione dell’Europa, come mondo continentale senza barriere, ha implicato l’abbattimento delle frontiere e la creazione di un mercato europeo della manodopera e del capitale. Le conseguenze di questo fenomeno sono state molteplici. Da un lato ha comportato una maggiore integrazione tra gli stati europei, da un altro lato ha determinato fenomeni di integrazione sociale non sempre facili, ma meno problematici dei più recenti e drammatici:
Nel 1973, nella sola RFT, c’erano quasi mezzo milione di italiani, 535.000 iugoslavi e 605.000 turchi. I tedeschi – come gli svizzeri, francesi, i belgi o gli inglesi – non erano particolarmente felici per quest’improvvisa apparizione di così tanti stranieri. Per la maggior parte degli europei, vivere in mezzo a un folto numero di perone provenienti da terre sconosciute era un’esperienza completamente nuova. Se fu superata in modo relativamente tranquillo, a parte qualche occasionale scoppio di pregiudizi e violenze, lo si deve in varia misura al fatto che i lavoratori stranieri vivevano separati dalla popolazione locali, in tristi sobborghi alla periferia estrema delle grandi città, al fatto che, in fase di piena occupazione, non rappresentavano una minaccia economica, al fatto che, almeno nel caso degli immigrati cristiani provenienti da Portogallo, Italia e Iugoslavia, erano fisicamente e culturalmente “assimilabili” (vale a dire, non erano di pelle scura o musulmani) e, infine, al fatto che si dava praticamente per scontato che un giorno se ne sarebbero andati.[6]
Da questo passo si può comprendere la distanza dei nuovi problemi di integrazione della manodopera. Se in Europa c’era già un sistema di valori morali ed estetici piuttosto uniforme, per quanto differenziato nelle sue particolarità, oggi l’integrazione ha portato a problemi più radicale per via degli immigranti di diverso colore della pelle, diversa religione e morale e abitudini sociali. Non bisogna nasconderlo mai: i problemi della convivenza tra popoli sono sempre state difficoltose per le stesse ragioni.
La vera rivoluzione dell’economia fu dovuta alla ridefinizione del potere d’acquisto della manodopera. La capacità economica della base fu aumentata e le conseguenze di questo fenomeno non hanno precedenti nella storia. Ognuno poteva comprarsi degli oggetti utili ed inutili in quantità impensabili prima. Questo ha determinato l’incremento della capacità produttiva:
Naturalmente, i nuovi lavoratori non si limitavano a produrre merci, ma le compravano anche. Era qualcosa di piuttosto nuovo. Per tutto il corso della storia, in Europa (e in qualsiasi altra parte del mondo), la maggior parte della gente aveva posseduto soltanto quattro generi di cose: quelle ereditate dai genitori, quelle costruite da soli, quelle barattate e scambiante e, infine, quelle poche che era stato necessario acquistare con denaro contante, quasi sempre prodotta da individui conosciuti personalmente. Nel corso del diciannovesimo secolo, l’industrializzazione aveva trasformato il mondo delle città, ma in molte parti dell’Europa rurale l’economia di tipo tradizionale continuò a vivere immutata, in certi casi anche dopo la fine della seconda guerra mondiale.[7]
L’unica critica reale che si può muovere a questo libro denso di informazioni e profondo sia nella ricostruzione globale che nella spiegazione particolare, è la particolare inclinazione politica di Judt, la cui preferenza per l’economia di mercato e un’ideologia (più che vagamente) conservatrice possono destare diffidenza. In particolare, Judt è un critico implacabile del comunismo nelle sue varie forme storicamente determinate, tanto nell’URSS che nei paesi sotto il patto di Varsavia. Non è possibile, in questa sede, elencare tutti i casi in cui Judt è inclemente nei giudizi contro la società comunista, né ha molto senso farlo. Egli, è vero, non va mai a trattare delle intenzioni, per così dire, del comunismo, ma, così facendo, cade nell’errore gravissimo di non sottovalutare i motivi per cui una quota straordinaria di persone sono state disposte a sposare la causa e l’ideologia comunista da un lato e dall’altro della cortina di ferro. Si può argomentare che la società comunista sia stata antidemocratica e incapace di rendere la società più libera e più efficiente. Ma non si può non considerare la profonda importanza dell’ideologia comunista sia come fonte di critica, sia come fonte di speranza. Questo non emerge minimamente, sebbene si enumerino tutti i vizi del comunismo reale, dai gulag al controllo dell’informazione da parte della Nomeklatura. Questa insufficiente considerazione del comunismo, come fenomeno sociale innovativo e critico per quanto concretamente inefficiente o incapace di mantenere le promesse, è la più grave mancanza dello storico, che finisce invischiato all’interno della sua visione personale, per quanto mai chiaramente dichiarata. Ciò nonostante è comunque capace di criticare gli aspetti più inquietanti delle liberalizzazioni massive e del liberismo economico operate dalla Tatcher:
Dal punto di vista economico, quindi, la Gran Bretagna thatcheriana era un paese più efficiente. Ma sul piano sociale subì un crollo, che ebbe conseguenze catastrofiche sul lungo periodo. Disprezzando e smantellando ogni tipo di risorsa collettiva, insistendo tenacemente su un’etica individualista che ignorava qualsiasi bene non quantificabile, la Thatcher arrecò gravi danni al tessuto connettivo della vita pubblica britannica. I cittadini furono trasformati in azionisti, e le loro relazioni reciproche e con la collettività misurate in termini di beni economici anziché di servizi e obblighi. Ora che tutto era finito nelle mani di compagnie private, dalle aziende di trasporti al rifornimento di energia, lo spazio pubblico divenne una piazza di mercato.[8]
In definitiva, si tratta di un lavoro monumentale, raro per completezza e precisione informativa, difficile da discutere sul piano della qualità, e anche gradevole da leggere, nonostante la sua lunghezza e densità. Il Judt dimostra, così, di essere un grande storico e di essere un interlocutore prezioso per chiunque voglia comprendere qualcosa del mondo che lo circonda, mondo che gli risulterà più comprensibile alla luce della lettura.
JUDT TONY
DOPOGUERRA. COM’E’ CAMBIATA L’EUROPA DAL 1945 A OGGI
MONDADORI
PAGINE: 1075
EURO: 12,00
[1] Judt T., (2007), Dopoguerra, Mondadori, Milano, p. 21.
[2] Judt T., (2007), Dopoguerra, Mondadori, Milano, p. 74.
[3] Judt T., (2007), Dopoguerra, Mondadori, Milano, p. 90.
[4] Judt T., (2007), Dopoguerra, Mondadori, Milano, p. 247.
[5] Judt T., (2007), Dopoguerra, Mondadori, Milano, p. 259.
[6] Judt T., (2007), Dopoguerra, Mondadori, Milano, p. 414.
[7] Judt T., (2007), Dopoguerra, Mondadori, Milano, p. 417.
[8] Judt T., (2007), Dopoguerra, Mondadori, Milano, p. 672.


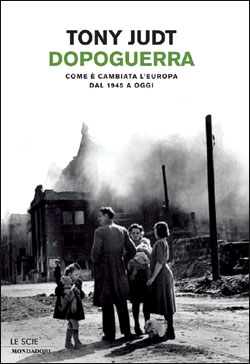


Be First to Comment