Abstract: Un quadro sintetico del pensiero di Hegel che mira a focalizzare il senso del suo filosofare. Si intende offrire una veduta delle ragioni teoriche che caratterizzano lo svolgimento del sistema. La filosofia di Hegel è una grande metafisica, un tentativo di dare spiegazione dell’immanenza dell’intero nello spirito. Spirito che si fa concreto e pieno di significato e che si libera gradualmente da ogni particolarità unilaterale, superando così il vaglio della storia per venire a coincidere con il carattere di interiorità, scevra da rappresentazioni sensibili, dell’autentico sapere concettuale.
Il problema della conoscenza
L’idealismo è l’evoluzione coerente dei temi portati alla luce dalla filosofia nel periodo che va da Cartesio a Kant, quando il razionalismo e l’empirismo si impegnano, su fronti differenti, in una febbrile ricerca di chiarezza sulla capacità di conoscere dell’uomo.
I prodromi di tale interesse si fanno presenti con la nascita delle nuove scienze, all’inzio della Modernità. Il nuovo mondo, che si stava profilando sotto gli sguardi più attenti dell’epoca, stava erodendo i pilastri della conoscenza della cultura antica. La Modernità appariva come una frattura nella storia, una rivelazione, un affrancamento dalle illusioni.
Quali sono state le cause degli errori degli antichi filosofi nel modo di considerare la natura? Fu Bacone a fornire una risposta apparentemente semplice e chiara nel Novum Organon. Bisognava rivedere i metodi di indagine, adottare criteri induttivi di ricerca, affrancarsi dalla soggettività e dal pregiudizio, ottenere in tutti i campi quell’oggettività che le scienze naturali avevano già realizzato.
Galilei infatti aveva diviso le qualità degli oggetti in qualità primarie e qualità secondarie. Tutto ciò che è quantità o estensione è oggettivo, appartiene all’oggetto, mentre le qualità come il colore, il sapore, la sensazione di calore, sono soggettive e non passibili di conoscenza.
Cartesio tuttavia comprende che quell’oggettività dipende dai sensi e dall’elaborazione concettuale di un soggetto umano imperfetto, quindi se ogni processo soggettivo rende dubitabile la conoscenza, ogni conoscenza è dubitabile.
Emergerà quindi lentamente, dalla parabola storica della Modernità, che il pensiero può avere per oggetto solo le proprie rappresentazioni o idee.
Severino spiega che sono tre le fasi storiche che caratterizzano l’evolversi del concetto di conoscenza. Nella prima fase il pensiero antico riteneva che il mondo vero, cioè esistente in sé, è ciò che il pensiero pensa; la cosa percepita e pensata dall’uomo corrisponde, almeno sulla base dell’elaborazione cognitiva superiore, alla verità, alla cosa in sé.
In una seconda fase, quella concernente la Modernità, si incomincia a ritenere che l’uomo può conoscere solo la rappresentazione, il pensato, l’immagine soggettiva della realtà. Con Kant diventa chiaro che proprietà quali lo spazio, il tempo, la quantità, la causalità, sono dentro di noi, sono quadri soggettivi (sebbene universali), sono condizioni a-priori dell’esperienza.
L’oggettività, è data da una sintesi unificatrice, l’attività del soggetto che ordina, rende coerente e struttura il molteplice sensibile offrendo una rappresentazione che è, sì coerente e indipendente, ma la cui natura è fenomeno. Intendendo questo come un apparire nel modo del soggetto di una realtà esterna, la “cosa in sé”, pensabile ma inconoscibile nella sua sostanzialità.
Certezza e verità dunque non coincidono, né immediatamente né mediatamente: la verità, intesa come natura della realtà, come l’essere delle cose, semplicemente, non può essere conosciuta dall’uomo, anche se può essere pensata.1
Ci appare una realtà, l’esperienza, appaiono una molteplicità di esseri indipendenti da noi. In una prima fase abbiamo certezza della loro esistenza e consistenza (realismo). Pensando, riteniamo di poter verificare quando i nostri concetti sono corrispondenti agli oggetti di cui abbiamo esperienza. Riteniamo così che ciò che è pensato è vero, che i nostri concetti sono veri, sono effettivamente e realmente descrizioni degli oggetti.
In una seconda fase però ci accorgiamo che tutto ciò che è pensato è un percepito, e quindi ancora un pensato. Le entità presenti ai nostri occhi, al tatto, ai sensi in generale, dipendono nella loro fisionomia dai sensi e dai modi in cui le pensiamo. Ci accorgiamo che non c’è un effettivo confronto possibile tra i percetti e gli enti percepiti, perchè un tal confronto presuppone sempre la percezione e il pensiero (fenomenismo). Ogni ente si divide quindi nel suo essere e nel suo modo di presentarsi a noi. L’essere tuttavia resta ipotetico, perchè per essere conosciuto deve appunto presentarsi a noi. La cosa in sé è l’essere, a cui la Modernità attribuisce causalità rispetto alle nostre rappresentazioni (fenomeni) che sono propriamente ciò che conosciamo, l’oggetto del nostro pensiero.
L’immanentismo idealista
La terza fase storica inizia con la filosofia postkantiana che rileva l’illogicità del dualismo in argomento. Ritenere che un oggetto esterno al pensiero abbia efficacia causale sul pensiero stesso, significa infatti conoscere come causa tale oggetto e pertanto significa conoscerlo. Ma se la causalità è una categoria a-priori della conoscenza, se appartiene al nostro modo di conoscere, se è applicabile solo ai rapporti tra fenomeni; non può essere pensata come causa dei fenomeni, giacchè sarebbe concepita come relazione esterna al pensiero.2
La filosofia postkantiana e l’idealismo negano quindi che possa esistere una cosa che sia ad un tempo pensata, causale, e sia anche fuori dal pensiero, perchè sarebbe come ammettere che è pensabile l’impensabile.
Il concetto di cosa in sé è contraddittorio, cioè nullo, la cosa in sé, intesa come un al di là inconoscibile, non esiste.3 E’ appunto da tali considerazioni che si diparte la filosofia dell’idealismo, in particolare di Shelling e di Hegel. L’idealismo di Fichte mantiene invece il concetto di cosa in sé, pur variandone il ruolo.
Si approda così ad un principio cardine, l’immanentismo, che è la concezione secondo la quale è impossibile trascendere il pensiero. “La coscienza infatti non si pone se non come una sfera il cui raggio è infinito; e qualunque sforzo si faccia per pensare o immaginare altre cose o coscienze al di là della nostra coscienza, quelle cose e coscienze rimangono dentro di essa, per ciò appunto che sono poste da noi, sia pure come esterne a noi. Questo fuori è sempre dentro.”4
L’oggetto infatti può essere descritto solo in base a proprietà, che sono concetti, idee. Possiamo ipotizzare un oggetto al di là, possiamo credere, possiamo immaginare, ma ipotizzare, credere, immaginare, sono ancora atti del pensiero.
Inoltre, se pensiamo al nostro stesso pensare come un pensare individuale tra molti, immediatamente i molti sono presenti, sebbene in actu exercito, all’atto del pensiero. Ovvero, qualunque sia il contesto entro cui collochiamo un pensato, questo sarà già trasceso dall’atto stesso che lo pone. Spiega chiaramente Gentile che: “Nel definire come oggetto determinato di un nostro pensiero la nostra stessa attività pensante, dobbiamo sempre ricordare che la definizione è resa possibile dal rimanere la nostra attività pensante, non come oggetto, ma come soggetto della nostra stessa definizione, in qualunque modo noi si concepisca questo concetto della nostra attività pensante. La vera attività pensante non è quella che definiamo, ma lo stesso pensiero che definisce”.5
Con Hegel si giunge pertanto a poter dire che il pensiero è intrascendibile. Ogni ente è vero (il vero è un concetto) e la totalità degli enti corrispondono ad una verità complessiva che offre intelligibilità al reale, oltre alla quale, nulla sussiste. Ma se qualcosa non è delimitato da nulla, allora è infinito e assoluto, quindi il pensiero è l’infinito orizzonte, assoluto, dell’intero.
Ancora, essendo il pensiero l’intero, appunto perchè nulla esiste fuori da esso, è autopoietico. Si fa da sé come infinito in autonomia e indipendenza da qualsiasi condizione che non sia posta da se stesso, è causa libera di se stesso e di tutti i suoi contenuti, è la sostanza del mondo. Il mondo quindi è pensiero, è movimento infinito, svolgimento di una coscienza universale.
Se pensiamo a qualcosa distinguiamo, cioè opponiamo l’ente pensato ad altro da sè. L’atto che costituisce questo pensare comprende quindi la cosa pensata e anche l’altro, rispetto al quale la distinguiamo. Vale certamente il principio di identità, perchè la cosa pensata è se stessa, ma vale quindi anche che omnis determinatio est negatio. Il pensiero che afferma, isola infatti una zona nello spazio logico rispetto ad un’altra, che comprende tutto ciò che il pensiero nega, tutto ciò che non è l’oggetto pensato. Rimane pertanto che se concepiamo una proprietà relativa a tutti gli enti o il concetto stesso di totalità, l’universo, allora questo presuppone una totalità più ampia e il processo si spinge all’infinito.
L’infinito tuttavia in Hegel non è un semplice rimando ad altro, una ripetizione dello stesso, ma è pensato come un circolo, il circolo che si costituisce come autocoscienza, riflessione della coscienza su se stessa in quanto altro da sé. Il circolo quindi è il processo di sviluppo dell’intero che partendo dalla semplice coscienza, acquisisce autocoscienza, attraverso una lunga serie di momenti che vengono via via superati e conservati. Sebbene possa apparire strano che qualcosa sia superato e conservato ad un tempo, ciò è effettivamente quello che accade nella formazione dell’autocoscienza o nella conoscenza. L’oggetto del pensiero che inizialmente appare distinto dal soggetto conoscente, si viene a costituire come significato, legge, relazione, funzione, è compreso nell’interiorità come verità e come elemento di un sapere più ampio che lo fa conoscere quale momento singolo del processo conoscitivo del soggetto. Rimane pertanto conservato nel soggetto pur essendo superato.
Pensare il pensiero del singolo è un pensiero che seleziona, un atto di pensiero che appunto, in quanto seleziona tra…, presuppone gli altri ed è quindi già proteso verso le altre singolarità. Il pensiero personale e individuale è nella sua intima essenza questa stessa presupposizione, porta in sé il presupposto dell’intero. Ognuno nel pensare è perciò parte di un tutto unitario in sé riflesso, un Io trascendentale che supera l’isolamento della singolarità e ad un contempo la conserva. “Il pensiero cioè, non è una cosa tra le cose: appunto perchè tutte le cose tra le quali lo si vorrebbe porre sono pensate, e quindi non è il pensiero a essere una tra le cose, bensì sono le cose tutte a costitutirsi e a svolgersi all’interno del pensiero, cioè all’interno dell’apertura del Tutto”.6
Dialettica
La dialettica è la legge del movimento di espansione del pensiero che giunge a definire sé in quanto altro da sé e lo fa nel determinarsi in totalità più estese ma anche più comprensive, totalità contenenti tutte le differenze.
Consiste schematicamente in tre momenti:
Il momento astratto o intellettuale: “Il pensiero come intelletto se ne sta alla determinazione rigida e alla differenza di questa verso altre: sifatta limitata astrazione vale per l’intelletto come cosa che è e sussiste per sé”.
Il momento dialettico o negativo razionale: “è il sopprimersi da sé di sifatte determinazioni finite e il loro passaggio nelle opposte”.
“Il momento speculativo o il positivo-razionale, concepisce l’unità delle determinazioni nella loro opposizione; ed è ciò che vi ha di affermativo nella loro soluzione e nel loro trapasso”.7
La dialettica non è tuttavia una procedura schematica e nemmeno un calcolo logico che da premesse obbligherebbe ad accettare una conclusione. Sarebbe proprio ciò che Hegel aborriva e che la dialettica tende ad evitare. Ogni passaggio dialettico nel sistema hegeliano è differente, specifico per ogni momento, di varia natura e complessità.
Nel primo momento la coscienza è in sé, possiede l’oggetto come alterità distinta, è cosciente solo dell’oggetto e delle differenze tra oggetti.
Nel secondo momento la coscienza è consapevole della distinzione tra sé e l’oggetto e della distinzione tra oggetti. L’oggetto è il suo negativo e ogni oggetto è il negativo dell’altro. Sa quindi che l’oggetto è tale per sé (stessa) e che ogni oggetto è tale per l’altro, è determinato da altro, perciò ha la propria natura nell’altro. Sa se stessa dunque, come determinata dall’oggetto, si conosce come riflessa in esso.
Ma anche l’oggetto è un riflesso della coscienza, ed è da essa determinato, tutti gli oggetti sono un riflesso della coscienza (il pensiero non è infatti una cosa tra le cose).
Nel terzo momento quindi la coscienza sa l’oggetto come riflesso di sé, si sa quindi come unità del soggetto e dell’oggetto, conosce l’oggetto in sé ma anche per sé. Essa conosce se stessa come determinante tutti gli oggetti ed è perciò autocoscienza che sa di essere tutte le cose.
“Ogni conoscenza e cultura, la scienza e l’azione stessa, non mira ad altro che ad esprimere da sé ciò che è intimo ed in sé, e cosi diventare oggetto a sé stessa”.8
La dialettica rappresenta il processo di produzione dei concetti, ovvero il processo attraverso cui è prodotta la realtà tutta. E’ la legge necessaria in base alla quale il pensiero dà forma a se stesso e conseguentemente alla realtà.
“Sottraetevi all’ordinaria e inconsapevole astrazione per cui la realtà è quella che voi pensate, mentre, se voi la pensate, non può essere se non nel vostro pensiero; mirate con fermo occhio a questa vera e concreta realtà che è il pensiero in atto; e la dialetticità del reale vi apparirà evidente e certa come certo ed evidente è a ciascuno di noi l’aver coscienza di ciò che pensa: il vedere, per esempio, quello che vede”.9
In questo passo Gentile ci dice che la dialettica è legge dell’attività pensante e non della realtà pensata, “Hegel appunto vide che non si concepisce dialetticamente il reale, se non si concepisce il reale stesso come pensiero: e distinse l’intelletto che concepisce le cose, dalla ragione che concepisce lo spirito: l’uno che si rappresenta astrattamente le cose analiticamente, ciascuna per sè, identica a sè, differente da tutte le altre; e l’altra che le intende tutte nell’unità dello spirito, come identica ciascuna a sè, ma anche diversa; e quindi diversa da tutte le altre, ma identica anche a tutte le altre”. 10
Si intende che la dialettica non è banalmente la coincidenza dei contrari ma è il rapporto secondo il quale i contrari sono gradualmente soppressi come contrari in quanto tutti ugualmente parti del medesimo intero.
E’ il principio dello svolgimento storico a-priori della coscienza che trascende ogni suo momento particolare nella costante presupposizione dell’altro, processo il cui scopo è l’identità del diverso o l’identità nella differenza. Ogni momento della formazione della coscienza, ogni “fase” che la coscienza concepisce come una totalità, come una verità fatta e finita, si rivela nel successivo svolgimento soltanto come parte di una più ampia sfera di significato. Il senso della dialettica è pertanto il necessario toglimento di ogni unilateralità dell’intelletto. Proprio in quanto ogni determinazione è tale nel pensiero rispetto ad altro, è un che di finito, il pensiero della singola determinazione trapassa infinitamente in altro. “Ogni finito ha questo di proprio, che sopprime se medesimo”.11 La differenza, in quanto ogni determinazione è negazione, è il confine che delimita sé rispetto ad altro e costituisce la reciproca determinazione degli enti pensati.
“Ma la cosa finita non è mai quell’essere uno, chiuso in sè, che essa sembra. Pel fatto solo che è limitata, ha un limite, cioè qualche cosa che agisce su di essa determinandola e negandola; la sua determinazione è appunto tale in virtù delle altre determinazioni che la definiscono e la condizionano.”12
Ogni determinazione è quindi il riflesso di ogni altra, è riflessa nel pensiero e possiede il riflesso del pensiero che è potenza, protesa a diventare atto. 13
La visione complessiva sarà quindi la conservazione delle differenze riflesse nella coscienza, intese come momenti del processo dell’intero, ma se l’intero è il pensiero stesso, la conseguenza sarà la consapevolezza che ognuno di quei momenti è un costituente dello stesso pensiero. Così come le foglie hanno verità come parti dell’albero, i momenti dell’intero acquistano senso e verità solo ed unicamente come parti del tutto, ma di un tutto pensante.
Ora, se l’intero è il pensiero dei suoi momenti completamente svolti, ecco che l’intero è riflessione del pensiero su se stesso, ovvero, pensiero di pensiero. Ma il pensiero che riflette sui suoi propri concetti, formati nel superamento delle rappresentazioni e delle intuizioni da se stesso liberamente poste, è un pensiero indipendente, cioè ab-soluto, ed è manifestazione (a sé di se stesso) cioè spirito. Spirito assoluto, la cui conoscenza è conoscenza assoluta dell’Assoluto.
Il sistema
Il sistema comprende la Logica, La filosofia della natura, La filosofia dello spirito. Ma qui si deve fare un passo indietro e immaginare cosa esiste… prima dell’esistenza stessa. Non c’è un inizio dell’intero giacchè è un circolo, ma c’è un cominciamento: l’inquietudine infinita dello spirito che è potenza d’essere ma ancora non è atto. Il tutto quindi è racchiuso in tale inquietudine, ma solo in potenza. Il cominciamento è l’indeterminatezza nel circolo infinito, è il “passato” del pensiero assoluto, ciò che esso pensa come dileguato, come momento primigenio della sua attività, che Hegel stesso definisce come “Dio prima della creazione del mondo”. Il concetto di “cominciamento” non ha un momento in cui non è ancora e un momento in cui è qualcosa; esso è qualcosa che ancora non è. Ecco perchè il filosofo parte dalle categorie più astratte, l’essere e il nulla, che in quanto astratte sono vuote e unilaterali e perciò equivalenti, e mostra come gradualmente si facciano concrete assumendo via via nuove determinazioni: il divenire, la qualita, la quantità, la misura, l’essenza, il fenomeno, la realtà in atto, il concetto, il concetto soggettivo, il concetto oggettivo fino a giungere all’idea. Ogni momento è un momento del concetto e dell’idea, che contiene altri momenti, tutti costituiti da unità triadiche discusse dialetticamente, che vanno a formare necessariamente il momento successivo. Tutto il sistema è il riempimento di quelle due categorie di partenza che si fanno progressivamente sempre più concrete.
L’idea è un concetto chiave, è sintesi, l’unità di tutti i momenti della Logica, comprende la struttura formale della realtà ma non è ancora la realtà stessa. E’ l’espressione dell’intelligibilità del reale, l’insieme delle determinazioni che significano, come in Kant, le condizioni a-priori dell’esperienza in quanto è pensata. Quindi l’originaria inquietudine dello spirito si completa con le categorie del pensiero formale, con la verità ancora astratta. La condizione razionale dell’esistenza è perciò il concetto di essere vero in vista di un fine, unità del concetto e dell’oggetto, interiorità in opposizione all’esteriorità.
“L’idea è la verità; perché la verità è il rispondere dell’oggettività al concetto, — non già che cose esterne rispondano a mie rappresentazioni; queste son soltanto rappresentazioni esatte, che io ho come questo individuo. Nell’idea non si tratta né di questo, né di rappresentazioni, né di cose esterne.—Ma anche tutto il reale, in quanto è vero, è l’idea; ed ha la sua verità soltanto per mezzo e in forza dell’idea”.14
L’idea, che si è data da sé l’esistenza, è libertà e conoscenza, ma proprio in quanto conoscenza è anche verità. Si è formata dunque in vista di uno scopo, perchè ha superato nel suo svolgimento il non vero dello spirito determinandosi; pertanto l’idea è volere.15
La natura
ll polo dialettico entro cui l’idea si è determinata, l’opposto che ne delimita il confine, è la natura, “[l’idea quindi] si risolve a lasciar uscire liberamente da sé il momento della sua particolarità, o del suo primo determinarsi e del suo esser altro: l’idea immediata, che è il suo riflesso, — come natura”.16
Nel farsi natura si aliena, è negata in un processo di particolarizzazione che trapassa, da ciò che era eminentemente universale e libero, a ciò che è meccanico ed eteronomo. Si tratta delle relazioni tra i corpi, tra enti individuali che vengono a manifestare se stessi nell’esteriorità reciproca, nell’isolamento dell’individualità. Ma la verità della natura è l’idea che, nel suo stesso alienarsi, trova nella natura, che essa stessa produce, se stessa come vita e anima. Diventa quindi per sé concetto in sé riflesso, spirito, ed è solo nello spirito che l’individualità della natura è in unità con l’intero ed acquisisce significato.
“La natura è in sé un tutto vivente: il movimento attraverso la sua serie di gradi consiste, più precisamente nel porsi dell’idea come ciò che essa è in sé; o, che è il medesimo, l’idea, dalla sua immediatezza ed esteriorità, che è la morte, torna in sé, per esser dapprima il vivente; e poi supera anche questa determinatezza, nella quale è soltanto vita, e si produce nell’esistenza dello spirito: — che è la verità e lo scopo finale della natura, ed è la vera realtà dell’idea.”17
Lo spirito
Il processo dialettico continua producendo tutti i concetti che definiscono lo spirito, prima soggettivamente poi oggettivamente. Lo spirito soggettivo è dapprima anima, poi coscienza, poi la coscienza diventa spirito oggettivo, ovvero il diritto, la moralità, l’eticità. Lo spirito soggettivo è la coscienza individuale mentre lo spirito oggettivo è la coscienza collettiva.
Con la Filosofia dello spirito, l’idea si oggettiva nell’uomo, nella singolarità di un anima che trasmuta in coscienza. Qui sta il punto d’unione tra lo spirito universalmente concepito e l’uomo singolo, ciò che lo rende capace di avere coscienza dell’intero. Ma non basta la sola coscienza per compenetrare l’essere come totalità; è necessario che la coscienza sia autocoscienza, e perchè ciò avvenga, essa deve dapprima divenire intelletto e riconoscere la natura come pervasa dalle sue leggi e successivamente deve riconoscere l’altra coscienza come un “se stesso libero”.18 “L’autocoscienza universale è il sapere affermativo di se stesso in un altro se stesso”.19 Riconoscendo le leggi della natura e l’unità delle autocoscienze, l’autocoscienza si costituisce nell’universalità; come “la certezza di essere ogni verità”.20 Non è più soltanto intelletto che analizza e separa ma è l’intelletto compreso nell’unità della ragione.
Ed è così che l’uomo, come afferma Sheler, è l’unico essere ad avere un mondo, una coscienza che si pone pertanto fuori dal mondo; sospeso tra questo esser fuori dal mondo e il suo essere nel mondo, l’uomo concepisce la causa del mondo come Dio. Nella filosofia di Hegel, Dio si fa con il mondo, e sia la storia dei popoli, sia le singole individualità, sono momenti del processo autopoietico del divino.
Lo spirito soggettivo è teoretico, ovvero conoscitivo, ma è anche spirito pratico, cioè volere morale. In questa parte del sistema, Hegel elabora la soluzione idealista al dualismo gnoseologico moderno e la soluzione al dualismo che permane tra la Critica della ragion pura kantiana e la Critica della ragion pratica. Dualismo che consiste nell’apparente inconciliabilità tra l’attività teoretica del pensiero e la coscienza morale.
L’attività teoretica dello spirito consiste nel porre l’oggetto sensibile come cosa “trovata”, cioè come apparentemente indipendente dal soggetto. L’oggetto è intuito nella coscienza come altro dal soggetto, cioè appunto come oggetto, ma in quanto è conosciuto immediatamente come il negativo della coscienza, il suo proprio negativo, esso è per la mediazione del pensiero, (che è il toglimento della contraddizione della cosa in sè) in essa riflesso e riconosciuto come oggetto appartenente alla coscienza. Ma essendo la verità dell’oggetto ciò che può essere espresso soltanto nel concetto, l’oggetto coincide con la sua verità, è la sua verità, ed è perciò riconosciuto dalla coscienza come un pensiero, un pensiero da essa stessa posto come oggetto. E’ superata quindi l’iniziale alterità, che viene ora compresa come visione del particolare isolato dall’intero. Isolato cioè dal pensiero stesso, che in opposizione all’oggetto, nella sensibilità, trovava il suo limite e si particolarizzava come soggetto di un oggetto.
“L’intelligenza che si sa come ciò che determina il contenuto, – che è tanto il suo proprio, quanto è determinato come fornito di essere . È il volere”. […] Lo spirito come volere si sa come quello che delibera da sé in sé e si riempie da sè”.21
Si vede pertanto che la facoltà dello spirito di determinare il suo oggetto è libera ed in questa libertà lo spirito “ha la sua determinazione interiore e il suo scopo”.22 In ciò l’attività teoretica viene a coincidere con l’attività pratica.
“Ma l’attività finale di questo volere è di realizzare il suo concetto, la libertà, nell’aspetto esteriormente oggettivo, come un mondo determinato mediante il concetto, cosicchè il volere si trovi colà come in se stesso, congiunto con se stesso, e il concetto sia quindi compiuto come idea”.23 In ciò consiste lo spirito oggettivo che realizza se stesso come materia indipendente e autonoma nel diritto, nella morale e nell’etica. Lo spirito entra nella storia, dapprima come diritto, poi come moralità, “come il diritto del volere soggettivo”, poi come unità del diritto e della moralità, ovvero come sostanza etica, l’ethos di un popolo. L’eticità si realizza pertanto come famiglia, come società civile e come Stato.24
La sostanza etica che si compie nel concetto di Stato è lo spirito di un popolo ed è nel tempo. Lo spirito edifica se stesso attraverso la storia il cui svolgimento e momenti, sono gli spiriti dei vari popoli. “L’autocoscienza di un popolo particolare è portatrice del grado di svolgimento che ha luogo per quel periodo”.25 Ma ogni unilateralità deve essere superata, per cui ogni singolo popolo, ogni singola civiltà, giunge al decadimento. Cancellando quelle unilateralità esteriori che sono i costumi, le leggi e gli interessi temporali particolari, lo spirito conquista la sua universalità come spirito assoluto.26
Se torniamo un passo indietro, lo spirito assoluto muove dall’eticità che “è lo Stato ricondotto alla sua interiorità sostanziale […] ma la sostanzialità dell’eticità stessa dello Stato è la religione. […] Non ci possono [infatti] essere due diverse coscienze, una religiosa e una etica che sia diversa dall’altra pel contenuto.”27
Lo spirito assoluto ha come contenuto Dio, cioè se stesso, la verità assoluta e ha come forma la religiosità in sé e per sé, che è in unità con l’eticità.
Ma tutto ciò deve anche essere storico e pensato nel concetto. Lo spirito del mondo infatti ha già purificato la religiosità dai residui esteriori con la Riforma. “Così alfine il principio della coscienza religiosa e della coscienza etica diventa una e medesima cosa nella coscienza protestante”.28 La Riforma infatti nega le opere esterne, si contrappone a tutto ciò che assoggetta lo spirito a un’esteriorità per ritornare alla dimensione interiore e soggettiva della fede.
Ecco che lo svolgimento dello spirito assoluto è dapprima arte (in particolare arte religiosa), poi religione e in ultimo filosofia. Siccome l’arte, “fa dell’elemento naturale nient’altro che un’espressione dello spirito, che è la forma interna che manifesta solo se stessa;[…]l’apparire dell’arte annunzia la fine di una religione, la quale sia ancora legata all’esteriorità sensibile”.29L’arte segna dunque il passaggio dalla religione particolare e unilaterale alla religiosità. Il riferimento è al Rinascimento in cui il fiorire dell’arte cela il decadimento della religione Cattolica per inverarsi come religiosità nella Riforma.
Nell’arte il concetto è dato solo come intuizione sensibile del bello, come qualcosa di puramente formale, ma è nella religione che lo spirito ottiene una vera rappresentazione unitaria di sé. Il pensiero rappresentativo tuttavia non è ancora concetto, sta in una relazione esterna rispetto ad esso. Solo la filosofia, quindi, che è pensiero concettuale, può esprimere l’identità dello spirito con se stesso.
Il contenuto sostanziale dello spirito dapprima è intuitivo nell’arte, è unificato nel pensiero rappresentativo della religione ed è elevato a pensiero consapevole di sé nella filosofia, dove l’idea torna a se stessa e produce eternamente se stessa come spirito assoluto.
In sintesi
Lo spirito quindi, che era idea, nella natura e come spirito soggettivo, si particolarizza e si fa concreto, per poi espandersi nuovamente in un’universalità oggettiva che è dapprima lo Stato e successivamente lo spirito del mondo. Esso quindi ha come proprio negativo, in cui si riflette, la storia politica dei popoli e in essa agisce, dandole il fine. Ma per giungere alla consapevolezza di sé, deve esser riflesso in una sostanza pensante universale e indipendente espressa concettualmente. Trova quindi nello svolgimento storico della filosofia la sua stessa sostanza e il suo concetto, in essa si realizza come soggetto in unità con l’oggetto.
“La filosofia non ha il vantaggio, del quale godono le altre scienze, di poter presupporre i suoi oggetti come immediatamente dati dalla rappresentazione, e come già ammesso, nel punto di partenza e nel procedere successivo, il metodo del suo conoscere”.30
E’ essa stessa a porre i suoi oggetti ed in essa lo spirito assume gradualmente la coscienza di aver posto un mondo. Infatti, tutto ciò che è, è nel pensiero, è un pensato riflesso nella sostanza pensante, la quale proprio perchè pensante, diventa autocosciente quando riflessa nel pensato in quanto pensato. Ma ciò in cui ogni pensato è riflesso, ciò che ha per oggetto l’intero, l’attività di riflessione sulla totalità pensata, è quel pensato che non pensa immediatamente un oggetto dato, ma ha potenzialmente un oggetto nell’irrequietezza del presupposto della totalità. In tal sfera, che è l’orizzonte della coscienza pura, la filosofia, che non presuppone alcuna singolarità, pone liberamente il suo concetto, in se stessa riflesso e pertanto riflesso nell’orizzonte puro della coscienza, nella sostanza pensante che è lo spirito nel suo compiersi.
“Spogliando i concetti fondamentali che appaiono nella storia della filosofia di tutto ciò che concerne la loro formazione esteriore, la loro applicazione al particolare e cosi via, si ottengono i vari gradi della determinazione dell’idea”31
E ancora: “ogni filosofia è stata ed è necessaria, nessuna è trapassata, bensì tutte si sono conservate nella filosofia quali momenti di un tutto affermativo. Però dobbiamo distinguere fra il principio particolare di queste filosofie come particolare, e la realizzazione di questo principio attraverso tutta la concezione mondiale. I principî si sono conservati, ed essendo la più recente filosofia il risultato dei principî anteriori nessuna filosofia venne mai confutata. Ciò che venne confutato non fu il principio di questa filosofia, bensì il fatto che questo principio potesse essere considerato come determinazione ultima e assoluta”.32
Bibliografia:
A.A.V.V., Il Pensiero Occidentale dalle Origini a Oggi, 1983, Brescia.
E. Severino, La Filosofia Moderna, 1994, Milano.
M. Heidegger, La Fenomenologia dello Spirito di Hegel, Napoli ,1988.
G. Gentile, Teoria Generale dello Spirito come Atto Puro, 2012, Firenze.
P. Martinetti, Il Metodo Dialettico, in: Rivista di Filosofia, Bologna, 1931.
G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, 2008, Milano.
G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, 2008, Milano.
G.W.F. Hegel, Introduzione alla Storia della Filosofia, Bari, 1925.
Note:
1 E. Severino, La Filosofia Moderna, pp. 209-211.
2 A.A.V.V., Il Pensiero Occidentale dalle Origini a Oggi, pp. 33-35.
3 E. Severino, La Filosofia Moderna, pp. 205-206.
4 G. Gentile, Teoria Generale dello Spirito come Atto Puro, p. 32.
5 Ibid. pp. 8-9.
6 E. Severino, La Filosofia Moderna, p. 212.
7 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, pp. 96-97.
8 G.W.F. Hegel, Introduzione alla Storia della Filosofia, p. 41.
9 G. Gentile, Teoria Generale dello Spirito come Atto Puro, p. 57.
10 Ibid. p. 54.
11 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, p. 96.
12 P. Martinetti, Il Metodo Dialettico, in: Rivista di Filosofia, p. 286.
13 G.W.F. Hegel, Introduzione alla Storia della Filosofia, p. 39.
14G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, p. 198.
15Ibid. p. 189.
16Ibid. p.199.
17Ibid. p. 210.
18Ibid. p. 426.
19Ibid. p. 428.
20 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello Spirito, p. 333.
21 G.W.F. Hegel, Enciclopedia delle Scienze Filosofiche in Compendio, p. 462.
22Ibid. p. 476.
23Ibid.
24Ibid.
25Ibid. p. 524.
26Ibid. p. 525.
27Ibid. p. 527.
28Ibid. p. 536.
29Ibid. p. 543.
30Ibid. p. 1.
31 G.W.F. Hegel, Introduzione alla Storia della Filosofia, p. 50.
32Ibid. p. 57.


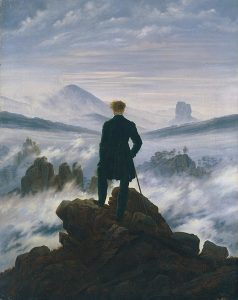


Be First to Comment