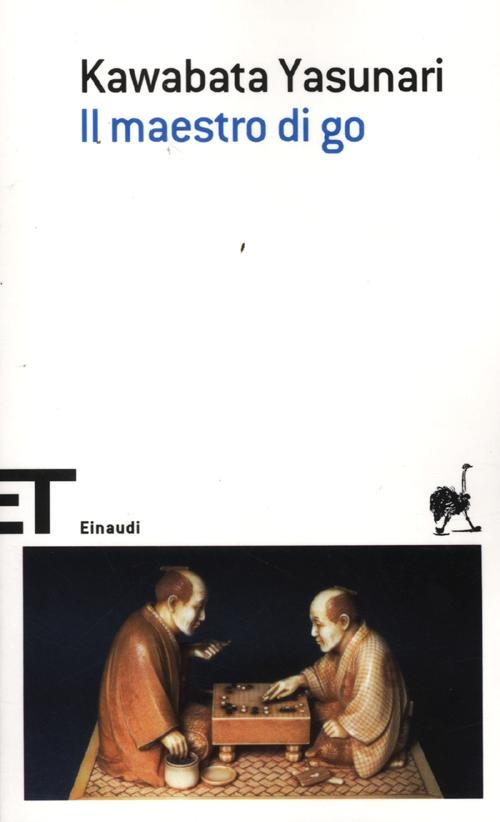
Iscriviti alla Newsletter!
Consigliamo Breve trattato sulla sottile arte del Go
Il maestro di go (1942) è un romanzo del premio nobel Yasunari Kawabata, nel quale viene narrata la storia dell’ultima partita di uno dei più grandi giocatori di go della storia, “Il maestro Shūsai, il ventunesimo discendente della famiglia degli Hon’inbō”.[1] Il gioco del go è uno dei più antichi giochi di strategia conosciuti, se non il più antico: “La nascita del Go è databile tra il 4000 ed il 3000 a.C., nello stesso momento in cui nacquero sulle rive dello Hoang Ho la matematica e l’astronomia cinesi. Altre congetture ne collocano l’origine in Tibet od in luoghi sempre però nell’area di influenza della cultura cinese”.[2] Essi non sono sostanzialmente paragonabili al più noto gioco di strategia dell’Occidente: gli scacchi.
Lo scopo del gioco non è quello di catturare più pezzi, o di sconfiggere una particolare pedina. Il gioco del go consiste nella conquista dello spazio, elemento concettuale ben noto agli studiosi di storia militare e warfare. Lo spazio nel go è l’elemento fondamentale, già presente, al momento del piazzamento delle pietre (le pedine di gioco). Il tempo è dato dal momento in cui si piazzano le pietre. L’universo del go nasce vuoto, il mondo del puramente possibile, laddove gli intrecci del goban più grande sono 381. Quanto ampio sia il mondo delle possibilità del go lo mostra il fatto che solo alla prima mossa (cioè alla prima semimossa del primo giocatore e del secondo) sono possibili 381×381 possibilità di piazzamento delle due pietre. Negli scacchi sono 400.
Lo spazio vuoto consente la coesistenza di due forze contrapposte, i neri e i bianchi che si confrontano per la contesa dello spazio vitale. In questo senso, le pietre dei due schieramenti non sono che i limiti del proprio regno, per questo esse sono solo uno strumento non il fine, sacrificabile. Come in guerra, anche nel go sussiste la cattura degli avversari che poi vengono restituiti alla fine: i prigionieri costituiscono il pegno finale dello scontro, come nelle contese di ogni epoca.
A differenza che negli scacchi, il mondo del go è puramente conservativo. Vale la legge di conservazione della massa. I giocatori non dissolvono le pietre avversarie. Le inglobano. Una volta terminata la partita i prigionieri devono essere ricollocati negli spazi dell’avversario e così gli sottraggono spazi conquistati. Quando imparai a giocare a go, con il mio migliore amico, costui, entusiasta, mi disse: “E’ un gioco per pacifisti. Nessuno muore”. Forse è così. Sicuramente non è un gioco pacifico. E non è un caso che mio padre, quando gli spiegai le regole del gioco e gli riportai la succitata frase, mi disse: “Ah, ma non è vero. Alla fine, questi prigionieri sono dei ripudiati! Me li riprendo controvoglia”. Forse c’è del vero e del falso in entrambe le visioni. Come in tutte le interpretazioni.
Il gioco del go è un mondo che tende verso il pieno partendo dal vuoto, in cui l’entropia avanza con l’avanzare delle mosse. All’incontrario che negli scacchi, dove il mondo va semplificandosi mossa dopo mossa: l’andamento di una partita di scacchi segue un percorso che va dal semplice (posizione di partenza) al complicato (mediogioco) ad uno stato ancora più semplice (il finale). In questo senso, si dà una curva di complessità che tende ad invertirsi o interrompersi. Il go, invece, è un universo nel quale l’elemento demografico determina la complessità dell’universo. Gli scontri si moltiplicano, gli stati di interesse diventano molteplici e ritrovare l’unità è possibile solo all’occhio del campione, il quale riesce a gestire il punto e la massa nella prospettiva di una chiarezza che si perde nel molteplice.
Negli scacchi c’è solo un vero obiettivo: l’abbattimento del re. Nel go è la conquista di una porzione dell’universo, possibile solo a condizione che il proprio ordine sia il più virtuoso. Non c’è spazio per un armistizio: solo un ordine trionferà perché nel go non sono possibili le patte.[3]
Non si potevano lesinare due parole per il gioco, perché il libro è intessuto dello spirito del go nel suo aspetto più alto: la contemplazione del go non come un gioco ma come un’arte.[4]
La storia, tutto considerato, è piuttosto lineare. Il maestro Shūsai deve disputare la sua ultima partita di go, prima del ritiro ormai necessario per via della sua vecchiaia e della sua malattia. Il suo compito non è facile. Gli si oppone il fortissimo VII dan Ōtake. La sfida si disputerà in un tempo molto lungo e si protrarrà per mesi. Alla fine, un intero mondo cesserà di esistere per far spazio al sorgere di un nuovo ordine.
Ogni atto di gioco deve essere il momento della concentrazione massima, della massima tensione, dell’appianamento di ogni dubbio e problema. Nonostante le moltitudini di possibilità che vanno escluse, nel momento del piazzamento della pietra si deve essere sicuri che sia la mossa giusta o la più vicina alla perfezione. Tempi lunghi giustificati sia per aiutare fisicamente il maestro, sia per consentire la massima possibilità di sviluppo di un gioco più vicino possibile alla perfezione.
Il conflitto tra il maestro Shūsai e Ōtake si gioca su molteplici piani e non tutti sono accessibili al maestro. Costui era uno degli ultimi giocatori professionisti di go che concepiva il goban come l’universo della creazione artistica, di un’opera fondata su leggi imperiture e immortali la cui contemplazione è superiore e indipendente dalla comune percezione della realtà. Ma così non è del tutto per Ōtake e per la nuova generazione di giocatori professionisti, i quali avevano come scopo principale quello di fare più punti. Di vincere. Vincere! Unicamente vincere. I mezzi per ottenere la vittoria possono essere diversi. Così, con in mente questa nuova realtà che aveva sostituito il concetto sacrale e puro per un gioco che nell’oriente giapponese era assimilabile ad un’arte e ad una forma di misticismo, le nuove regole per le partite divenivano espediente utile per ottenere l’ultima parola sull’avversario:
Si può dunque ben dire che nella sua ultima partita a go il maestro fosse perseguitato dalla razionalità dei tempi moderni che aveva ridotto il gioco a un insieme di regole cavillose; era ormai andato perso il senso del go come arte, la sua estetica, e il rispetto per gli anziani era stato negato, così come la reciproca stima dei giocatori per le loro qualità umane. La via del go non aveva più nulla della virtù e della bellezza dell’Oriente, soffocate dalla freddezza dei conteggi e di regole. Anche l’avanzamento nella scala dei dan che governava la carriera dei giocatori ormai non era che un computo di alta precisione, e in primo piano era assurto lo spirito di competizione, un agonismo il cui unico scopo era la vittoria, talmente esasperato da togliere ogni spazio alla riflessione sull’arte, alla sua fragranza.[5]
Molti di quanti leggeranno queste pagine sono abituati già all’idea che le cose stiano così e non potrebbero stare altrimenti. Nel mondo occidentale ogni peso e misura è dato dal successo. Cioè dalla vittoria. L’idea che questa non sia che il mezzo secondario di un atto che ha un valore ben più alto, ci è sostanzialmente estranea. Si può imparare, certo, ma risulterà frutto di un apprendimento adulto, non connaturato a quello che viene generalmente pensato dal resto della massa dei nostri vicini e, per tanto, ci sarà sempre in noi lo spazio per il dubbio che si stia pensando ad un’inezia. La vittoria negli scacchi è sempre stato quasi tutto. Se non tutto. Anche negli scacchi c’è lo spazio per un’estetica, ma questa deve passare irrimediabilmente per le mosse più efficienti, più forti, vincenti e, spesso, per quelle più aride di idee ma più utile sul piano concreto.[6] Ma questo vale anche per altri giochi, se non la gran parte. L’Occidente si concentra nello studio dei vincitori, anche quando questi sono assai mediocri. In noi è connaturato quel che oggi è noto come ʽeffetto qwertyʼ: come tutti sappiamo, la tastiera “qwerty” è quella utilizzata da tutti noi. Eppure è noto che questa non è la migliore delle tastiere possibili, sia per questioni di apprendimento che di utilità. Ma siccome è quella che si impose in un torneo di velocità di scrittura… Siamo tutti dei qwerty. E l’idea che un secondo, un terzo o addirittura un quarto possa essere più degno di un primo ci risulta automaticamente sospetta.
L’Oriente incominciava a prendere atto che ora anche l’Occidente si stava intromettendo nei suoi affari e la contaminazione inizia dall’aut aut che gli occidentali hanno sempre imposto agli altri: o la nostra visione delle cose o niente. Era la seconda guerra mondiale che Kawabata pubblica il suo libro. E tutta la tensione e distanza tra il mondo giapponese e quello occidentale emerge nella ironica sfida tra l’autore del libro e un giocatore americano in treno:
Sembrava a suo agio [il neofita americano] anche quando perdeva, e affrontava una sconfitta dietro l’altra con l’espressione sorniona e distratta di chi ritiene una sciocchezza sforzarsi più di tanto per vincere. Scendeva in campo con tattiche ben precise, seguendo quanto gli era stato insegnato, e partiva splendidamente per poi perdere subito la grinta. Se lo respingevo un po’ indietro o lo coglievo di sorpresa, crollava senza opporre resistenza, senza neppure provare a contrastarmi: era come lottare contro un uomo tanto robusto quanto irresoluto, e arrivai ad avere la sgradevole sensazione che in me fosse connaturata un’indole malvagia. Non era una questione di volontà bensì di volontà di reazione. Mancava in lui il senso di competitività. I giapponesi al contrario, per quanto deboli, sono sempre animati dallo spirito agonistico, è impossibile trovare in loro una simile arrendevolezza. L’americano contraddiceva lo spirito stesso del go. E io provavo nei suoi confronti un senso di estraneità, sentendo tutto il peso delle differenze culturali.[7]
Questo passo amaro mostra tutta la distanza tra due mondi che ormai si trovano a dover convivere tra loro. I cinesi e i giapponesi, due culture entrambe convinte di essere di discendenza divina (ma quale popolo non lo vanta?), non più reggono il confronto tra loro. Devono accettare di dover conoscere anche gli altri. E questo nel modo più doloroso. Mediante un confronto che impone delle regole ben precise, regole che si sostanziano su un concetto e valore ben lontano dalla loro natura: il riconoscimento della futilità delle cose ultraterrene.
In tanti dicono che l’Occidente ha perso il concetto del sacro. Vien da chiedersi se l’abbia mai avuto. Anche le religioni occidentali assai spesso sono state lo strumento di una ragione sovrastante sulla cultura degli altri, espedienti di conquista, di eliminazione, di pulizia. E così l’americano gioca tanto per fare. Si diverte. Perde e ricomincia. Perde e ricomincia. L’ordine del go è semplicemente l’ordine del gioco. Un gioco, appunto. Che inizia e finisce col piacere, con il diletto. E non è un caso che l’americano si fondi sull’espediente tattico. Perché l’Occidentale fonda tutto sul calcolo, sulle somme algebriche, che gli tornano o non gli tornano, ma possono essere materialmente visualizzate. E’ qualcosa che si può toccare. Un calcolo si può esibire, se ne sente addirittura l’odore. Un ordine superiore non è impensabile. E’ semplicemente una sciocchezza. Ben ci credano gli altri. A noi i cibi e le bevande. A noi la ragione della forza su ogni ulteriore ordine ultraterreno, fosse anch’esso incarnato nelle cose:
A Hakone avevo più volte sentito dire che nella Germania di Dueball c’erano ormai più di cinquemila appassionati di go e che anche in America il gioco stava iniziando a diffondersi. Malgrado questo, e nonostante la consapevolezza di quanto fosse incauto prendere come esempio quel principiante americano, ritenevo ugualmente che in Occidente lo spirito del go venisse negato. In Giappone è una “via”, un’arte che trascende la nozione stessa di forza e gioco. In esso confluiscono la mistica e la nobiltà dell’Oriente.[8]
Queste riflessioni dell’autore consentono di vedere gli occidentali per quei pragmatici insensati che sono assai spesso. E di come credono sovente che imporre una particolare visione del mondo sia capace di sostituire il mondo. Questo non significa naturalmente negare il fatto che quest’atteggiamento di credersi i primi sia esclusivo dell’Occidente. Ma del fatto che per l’Occidente vale la bella e profonda frase di Orson Welles: “Sono le uniche condizioni che un uomo rispetta. Le proprie”.[9]
Il risultato dell’impietoso confronto culturale fluttua e si concretizza nella sfida tra Shūsai e Ōtake. Il primo contemplativo, completamente immerso nel go, lasciava che la moglie si occupasse di tutte le sue preoccupazioni materiali. Compreso il disturbo di parlare. Egli si immergeva in molti giochi, perdendo completamente la cognizione della realtà, così come siamo abituati a considerarla:
Riguardo ai giochi il maestro era come indemoniato. (…) E’ normale che dei professionisti del go amino anche altri giochi, ma l’atteggiamento del maestro era diverso. Non riusciva a giocare con leggerezza. Non conosceva la moderazione. Era mosso da un’ostinazione ossessiva. Non riposava mai, né di notte né di giorno. C’era qualcosa di strano in lui, quasi fosse divorato dal demone del gioco, e il suo non era semplice passatempo”.[10]
Questo passo può naturalmente essere spiegato in chiave psicologica: “quasi fosse divorato dal demone del gioco…”. Ma si può supporre una spiegazione più sottile. Il maestro non viveva di questo mondo. Egli, si, aveva bisogno delle energie della materia e per questo gli toccava anche mangiare e dormire, di quando in quando. Ma erano dei momenti di necessità, la parentesi del suo modo superiore di concepire le cose della vita. E’ la vita ad essere disordinata, superflua. Per ciò sacrificabile. Nella purezza dell’ordine immateriale, della pura contemplazione della perfezione di regole imperiture e permanenti, egli ritrovava sé non come individuo ma come parte di un tutto di cui egli era solo un esecutore. Mosso dalla perfezione e non per la perfezione, dissipava se stesso per un significato, per la contemplazione di un mondo privo di impurità. La pura contemplazione della forma astratta, non era la risposta del maestro alla sfida della sopravvivenza. Perché rispondere alla brutalità già significa porsi nella brutalità. Egli semplicemente andava e tornava tra due mondi, il secondo dei quali consentiva di vedere il primo nella sua lucida inutilità o, per meglio dire, nella sua superfluità. Allora la morte e il dolore assumono dei significati assai relativi: “Perfino a mahjong e a biliardo, esattamente come nel go, egli finiva per elevarsi al di sopra di tutto, e di sé, e anche se i suoi avversari si irritavano, era sempre assolutamente sincero, la sua era una purezza perfetta. Diversamente dagli altri, che si limitavano a concentrarsi, egli sembrava perdersi in uno spazio remoto”.[11]
Il maestro dava il suo massimo al go, la somma arte, somma visione di un ordine superiore e sovrastante per il quale la vita è una funzione e non un fine: “Il maestro era divenuto una figura tragica. Il giornale aveva riportato l’affermazione che il suo ultimo desiderio era di finire i suoi giorni sul goban, giocando fino all’ultimo, e questo lo aveva reso un martire dell’arte”.[12]
Ma il tempo del maestro era terminato. Egli era in zeitnot, come si dice a scacchi, nel momento della mancanza di tempo. Lo spirito dei tempi era contrario ad un immaterialismo filosofico incarnato e ad una visione così improduttiva delle cose. Perché se le cose sono la misura e peso di ogni valore, allora solo ciò che può produrre può essere riconosciuto come sensato. E’ evidente che Shūsai non faceva più parte di questo ordine e, proprio per questo, la sua figura diventa tanto più tragica, come un faro antico che debba diffondere la luce in un oceano la cui violenza è irrefrenabile.
Ōtake si avvale di espedienti estranei alla mentalità del maestro, alla mentalità di colui che vede il proprio operato come unicamente vincolato alle somme leggi della perfezione. Ōtake prima di tutto vuole vincere, si deve sforzare per riconoscere le necessità umane del maestro, e l’autore lascia intendere che utilizzi i tempi di gioco e le nuove regole in modo da sfavorire la serenità del maestro. La vittoria di Ōtake non del tutto dovuta a lui, quanto allo spirito dei tempi, che ha ormai decretato la fine del mondo di Shūsai, che ormai non avrà che il tempo per terminare la sua partita, perdere e morire.
In questo libro unico si vive la contraddizione del concetto della realtà Occidentale e Orientale, e del trapasso dei tempi che sfociano nel presente fluire incessante delle cose, attraverso la duplice visione del go e del maestro. Il go si tramuta da momento sacro, da disputa ideale, a gioco. Gioco come tutti gli altri. La perdita dell’unicità comporta l’azzeramento della differenza tra ideale e concreto, tra momento di congiunzione mistica dell’anima ad un mondo ultraterreno o intramondano ma pur sempre perfetto. La vittoria sostituisce il capolavoro, la cultura viene soppiantata dalla produzione. Saranno le vittorie a costituire i capolavori e la produzione a costituire la cultura. Il sacro è dissolto. Il sacro ha perso. E nel nostro mondo non c’è spazio per la sconfitta:
Città irreale,
Sotto la nebbia marrone d’un’alba di inverno,
La gente si riversava su London Bridge, tanta,
Ch’io non avrei mai creduto che la morte tanta n’avesse disfatta.[13]
Yasunari Kawabata
Il maestro di go
Einaudi
Pag.: 231.
Euro: 11,00.
[1] Kawabata Y., (1942), Il maestro di go, Einaudi, Torino, p. 3.
[2] Soletti G., (2001), Note di Go, FIGG, p. 4.
[3] Ciò per la regola che al bianco devono essere aggiunti 5,5 punti, escludendo, così, la possibilità di pareggiare. Il bianco è il giocatore che gioca per secondo, a differenza che negli scacchi, e i 5,5 punti gli vengono attribuiti in virtù del fatto che egli ha il tratto dopo quello nero.
[4] Per considerazioni interessanti sul go e sugli scacchi, si veda l’interessante intervista al carissimo amico Francesco Marigo, più volte campione italiano di go e IV dan, http://www.scacchierando.net/dblog/articolo.asp?articolo=2637%20
[5] Yasunaru K., (1942), Il maestro di go, Einaudi, Torino, p. 51.
[6] Per questo aspetto, si veda Pili G., (2012), Un mistero in bianco e nero. La filosofia degli scacchi, Le due torri, Bologna.
[7] Ivi., Cit., pp. 113-114.
[8] Ivi., Cit., pp. 114-115.
[9] Welles O., Quarto potere, America, RKO, 1941.
[10] Yasunari K., (1942), Il maestro di go, Einaudi, Torino, p.108.
[11] Ivi., Cit., p. 108.
[12] Ivi., cit., pp. 100-101.
[13] Eliot. T., (1926), La terra desolata, Einaudi, Torino, pp. 19-21.




Be First to Comment